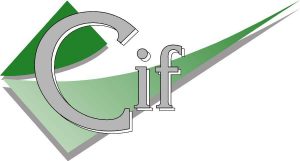Sull'HuffPost un estratto del libro di Aboubakar Soumahoro "Umanità in rivolta" - 13/04/2019
Aboubakar Soumahoro da molti anni difende i diritti dei lavoratori. Arrivato in Italia dalla Costa d’Avorio più di vent’anni fa, ha conosciuto da vicino le insidie di un tessuto civile che sembra sempre più logoro e incapace di garantire i diritti minimi che dovrebbero essere riconosciuti a ogni essere umano.
Pubblichiamo un brano dal libro di Soumahoro “Umanità in rivolta. La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità” edito da Feltrinelli e in libreria dall’11 aprile.
«La prima tappa fu Aversa, una cittadina a metà strada tra Napoli e Caserta, a pochi chilometri da Villa Literno. È una zona densamente popolata, perché una lunga striscia urbana la lega senza soluzione di continuità alla provincia di Napoli. Lì abitava un lontano parente che mi avrebbe dato una prima ospitalità. Quando arrivai nell’appartamento, però, scoprii che eravamo in quindici. Entrai, provai ad accendere la luce, ma non c’era la corrente. Niente male come inizio! Non avrei mai immaginato di trovare una casa senza corrente elettrica in una delle economie più avanzate del mondo. Il giorno dopo, quando decisi di andare a cercare un lavoro, avrei fatto altre scoperte. Dai miei compagni di casa venni a sapere che ci si doveva svegliare la mattina alle cinque e andare alla rotonda di Melito, nell’hinterland napoletano. Si arriva a piedi o in bicicletta e si aspetta che passi qualcuno in cerca di braccia, per lavorare come traslocatore, muratore o bracciante.
Funziona così: chi può offrire un lavoro si ferma, dà un’occhiata e sceglie, senza concordare né orario di lavoro né paga né luogo della prestazione. La sensazione è quella di essere merci esposte al mercato delle braccia, denudati della propria umanità. La mattina in cui, per la prima volta, sono arrivato alla rotonda c’erano asiatici e migranti da tutta l’Africa fermi ad aspettare. Una scena surreale, centinaia di persone in attesa, disponibili ad accettare qualunque lavoro e a qualunque condizione. Il giorno in cui non si trovava lavoro, l’alternativa era rimanere in piedi per ore nell’attesa, dopo essersi svegliati all’alba, e poi tornare a casa a stomaco vuoto e senza un soldo in tasca.
Quando si lotta con la precarietà di lavori occasionali, si vive alla giornata, ed è impossibile fare progetti. Ogni volta che sento i discorsi sulla pigrizia dei migranti, che non hanno voglia di far niente e vorrebbero vivere alle spalle degli italiani, penso a tutti quelli che ogni mattina alle cinque si alzano per andare alla rotonda di Melito, con la massima aspirazione di trovare per un giorno un lavoro massacrante a una paga misera. Ben presto anch’io cominciai a lavorare senza sosta. Passavo da un lavoro all’altro: in queste condizioni di precarietà esistenziale, non mi potevo permettere di rifiutare nessuna offerta. Riponevo tutta la mia speranza nel datore di lavoro di turno, o forse sarebbe meglio chiamarlo “padrone”, se la parola oggi non apparisse fuori moda.
Parlare di sfruttamento per molti significa essere ideologici. Al contrario, temo che sia “ideologico” rifiutare di vedere forme di organizzazioni sociali e del mercato che consentono a pochi di disporre delle vite degli altri. Spesso mi domando quanti sono gli uomini che sfruttano in privato le persone migranti, dicendo in pubblico che “i neri se ne devono andare via”. Anche se le condizioni di vita erano difficili, avevo la speranza che qualcosa sarebbe cambiato e che prima o poi ce l’avrei fatta a uscire dall’angolo. Ricordo ancora il giorno in cui un signore anziano si fermò al semaforo e mi “scelse”. Era un martedì, il giorno del mercato a Palma Campania, una cittadina a una trentina di chilometri da Aversa. La giornata al mercato era impegnativa, si trattava di caricare e scaricare i prodotti dal furgone. Non so per quale motivo lui decise di chiamarmi Davide: forse Aboubakar gli sembrava troppo complicato. Al termine della giornata, il “padrone” era contento di me e del mio lavoro e, lungo il viaggio di ritorno, gli chiesi la paga. Mi rispose che era molto soddisfatto e che avrei lavorato per sempre per lui già dall’indomani. Poi aggiunse in dialetto che non mi dovevo preoccupare per la paga della giornata perché mi avrebbe saldato tutto. Quello era stato una specie di giorno di prova, per tutto il resto, mi disse in dialetto napoletano, “m’ ‘o vvech’je”, ci penso io. Poi aggiunse: “Non preoccuparti, ci vediamo qui domani alla solita ora”.
Non mi sembrava vero, ero raggiante. Tornato a casa, dissi ai miei amici che mi avevano assunto e offrii la pizza a tutti. Il giorno seguente mi svegliai all’alba, non intendevo arrivare tardi all’appuntamento. Inforcai la bicicletta e mi misi a pedalare di buona lena. Arrivai in piazza che non erano neppure le sei ed ero tra i primi. Aspettai fino alle sette, niente. Poi le otto, le nove, le dieci, niente. Mi rifiutai di credere che “il padrone” mi avesse preso in giro, senza pagarmi la giornata e illudendomi con la promessa di un lavoro sicuro. Che motivo aveva? Risparmiare quei pochi soldi non l’avrebbe certo reso più ricco. E invece non si fece vedere, né quel giorno né mai. Anche se sono passati molti anni da quell’episodio, la rotonda di Melito è ancora oggi un punto dove si attende con speranza un lavoro, anzi, come si dice in dialetto napoletano, “‘a fatica”. Tutti quegli uomini in attesa, quelle braccia speranzose, sono diventati una presenza per molti abituale, parte integrante del paesaggio. Così come, a qualche chilometro di distanza, lungo le strade che da Aversa conducono verso Caserta o Lago Patria, decine di donne migranti attendono ai bordi delle strade gli uomini che le pagheranno per usare il loro corpo. Mi sono sempre chiesto quale fosse il prezzo di questa assurda normalità».